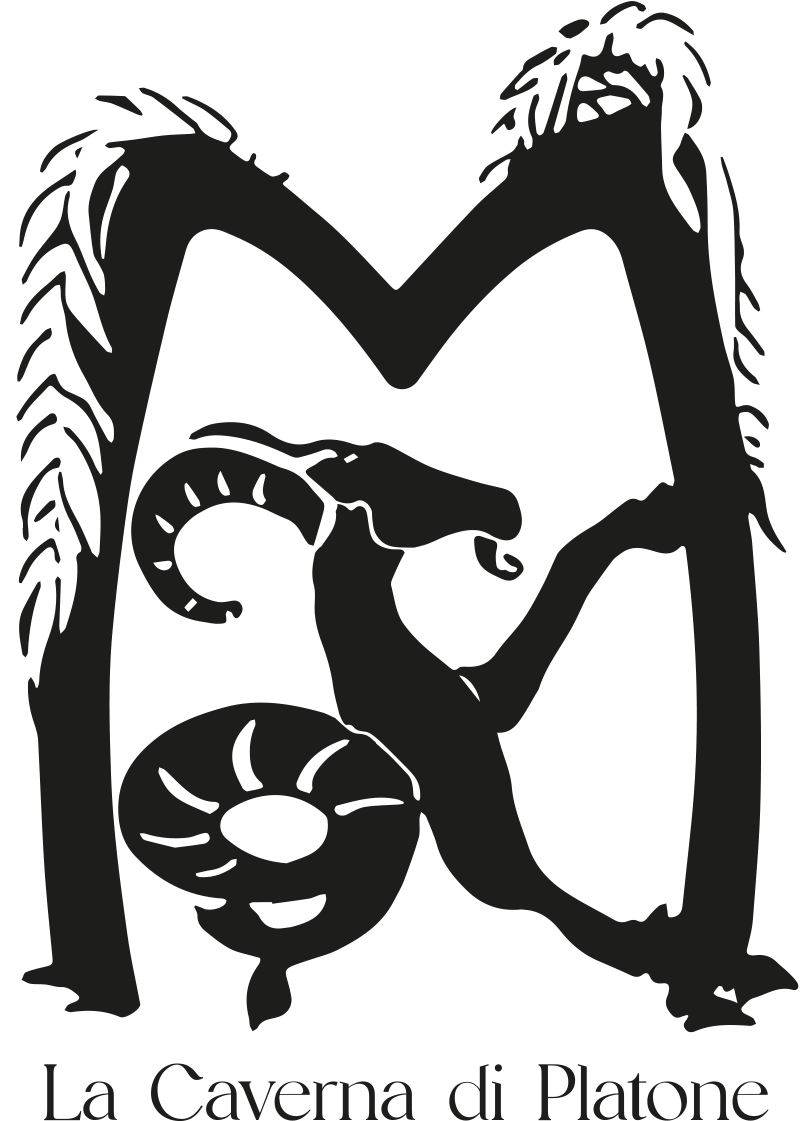La caverna di Platone, l’interiorità e la relazione
La cangiante proiezione digitale come riflesso nello specchio di angoscia e solitudine umana
Ai giovani e meno giovani di oggi alla ricerca di una esperienza di caverna – quella profonda che guarisce, che apre alla conoscenza del reale, al calore dell’interrelazione umana – propongo un viaggio multimediale lungo le vie della Iniziazione moderna, passando attraverso le vostre immagini, i vostri racconti personali; una discesa agli inferi nell’inconscio collettivo per poi entrare nel mondo dei sogni. L’archetipo della caverna ritorna nelle diverse culture come un luogo-grembo-origine della rinascita e dell’iniziazione; uno spazio che per l’antica tradizione greca rappresentava il mondo – e in particolare per il filosofo Platone – un luogo mitico per raccontare la possibilità di accedere alla conoscenza e liberare l’anima dalle ombre dell’illusione e dell’ignoranza.
L’archetipo della caverna ritorna nelle diverse culture come un luogo-origine della rinascita e dell’iniziazione; uno spazio che per l’antica tradizione greca rappresentava il mondo – e in particolare per il filosofo Platone – un luogo mitico per raccontare la possibilità di accedere alla conoscenza e liberare l’anima dalle ombre dell’illusione e dell’ignoranza.

‘‘Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l’entrata aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sí da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo.
Alti e lontani brilli alle loro spalle la luce d’un fuoco e tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una strada. Lungo questa pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini [… ] Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorate; e, come è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono…”
(Republica di Platone, VII, vol. II, Socrate parla con Glaucone).
Ancora una volta questa famosissima allegoria, ci può venire in aiuto per descrivere la vita odierna delle nostre giovani generazioni e la loro esperienza emozionale «incatenati» alla realtà virtuale dei loro telefoni, tablet e computer, dove trovano una loro identità in una immagine del mondo proiettato dal fuoco della tecnopoiesis (il fare tecnologico): un mondo simulacro!
Nel vissuto così febbrilmente veloce ed effimero della cangiante proiezione digitale, ecco che ci troviamo nella caverna, una sensazione ideale di essere contenuti, informati ma protetti in uno spazio mentale, una cella, riparata, dove è il mondo esterno ad essere visibile mentre da osservatori rimaniamo schermati e in controllo della nostra intimità. In questo rifugio si cerca di confrontare con l’apparenza e l’accelerazione della vita esterna, la propria interiorità, la propria personalità. Si cerca la ricreazione, a volte l’oblio delle proprie verità, il riposo dall’angoscia e dalla solitudine, si cerca spesso il conforto.
Nella caverna quindi come in uno spazio materno istintivo, il tempo si consuma nel qui e ora, nell’adesso e ci illudiamo che volendo conoscere, stiamo inseguendo quella «innata pulsione che spinge ad andare sotto le apparenze, verso la trama invisibile o la struttura nascosta, che conduce a quel mondo che è interiore a qualunque cosa data» 1
Per eccellenza l’immagine della caverna è materica, (mater-materia) così permane una sensazione che ci offre l’entrata in una assenza scolpita nella roccia che promette invece una strana presenza nascosta e una invisibile pienezza.

Forse rianima in noi un inattingibile ricordo di quell’utero in cui siamo cresciuti: il vuoto ci accoglie, si riempie di luci e di ombre, di forme e di storie, di attesa… Nonostante però, tutto questo nostro sentire e le nostre emozioni in merito, rimaniamo – come i prigionieri di Platone – ancora intrappolati nella madre fisica, nella materialità dei pixel e ingannati dalle ombre proiettate sulla parete, siamo solo al primo livello della conoscenza. Siamo al livello delle credenze, ciò che i sacerdoti di Platone volevano trasmettere con le forme, le figure e le statuine, fra le imitazioni confezionate per essere credute, che si presentano ai sensi perché la sensazione è solo quel momento superficiale e immediato attraverso la quale cogliamo la manifestazione esteriore, o l’apparire delle cose.
Ci si illude che la nostra personale interazione attraverso i social, si combina e vive con la comunicazione di massa, come ci si relazionerebbe nella piazza di un paese (auspicava Mark Zuckerberg), non rendendoci conto che già l’Intelligenza Artificiale sempre più spesso ci serve una dieta di clips, quei frammenti video, che vengono selezionati in base al nostro comportamento in rete, con ciò che ripetutamente scegliamo di visualizzare… per poterci confermare nei nostri bias e interagire invece non con gli altri, ma con il nostro riflesso nello specchio.
Fu la psicologia archetipica, con James Hillman, a coniare per prima il termine psicopoiesis (il fare anima). Sottolinea la distinsione fra ctonio e terrestre, tra fondamenta invisibile e terreno tangibile, tra profondità psichiche e profondità concrete. Invita a scendere metaforicamente in quella Caverna interiore dove la qualità spirituale del mondo infero emerge davvero, perché non più dominato dall’archetipo materno, e dalla materia ma dall’esperienza dello spirito, dell’Invisibile! Questa è una discesa nell’inconscio fra le forze rappresentate in qualche modo dal dio Ade. È la potenza delle profondità, dell’oscurità (per i Romani chiamato Plutone portava la ricchezza, o Trofonio, il nutrimento). Ade si nasconde nelle cose, esiste ed è sentito ma non lo si può vedere rappresentato, non si materializza mai nelle immagini che proiettiamo. Rimane nascosto, occulto, esoterico e si cela nel mistero… rivelandosi a tratti, solo nella relazione che un individuo riesce a stabilire con il simbolo.
La psicopoiesis, l’andare a fondo per raggiungere la struttura delle cose ci chiede di penetrare nella loro oscurità perché come diceva Eraclito «La natura ama nascondersi». Ci chiede di affrontare la violenza e l’aggressione (Ade rapisce Persefone dal giardino adolescenziale di sua madre per portarla in sposa negli Inferi), ci pone davanti la sfida di scavare nel sepolto, per trovare «colui che si nasconde» e di affrontare l’imprevedibile, lo spaventoso, l’inganno… ciò che non si vede (perché vietato, bloccato, nascosto in quanto interiore e inferiore). La psicopoiesis ci porta nella caverna dell’Iniziazione ai Misteri; quegli strani percorsi fra le ombre, dove i riflessi dei nostri racconti vengono scambiati per momenti reali e irripetibili del nostro essere. Ma dove alla fine del viaggio, avviene anche una trasformazione sublime; quell’esperienza indicibile (quel peak experience) che apre la mente alla comprensione: all’esperienza d’essere nell’immortalità, nell’immutabile e nell’eterno!
La conoscenza, la verità, per come la intendeva Platone la raggiungiamo solo quando le nostre «idee» diventano realtà autentica, strutture mentali che vengono riscoperte, associate, condivise, rivissute, attraverso la reminiscenza. Sono ciò che è presente nella mente sin dalla nascita, presente in tutti noi e intravisto in precedenti esperienze di vita ma dimenticato, ignorato nel nostro maniacale bisogno di affermare la nostra individualità illudendoci di essere autonomi. Una visione assoluta ed essenziale che prevede l’incontro accogliente nella memoria collettiva e l’integrazione dopo un viaggio coraggioso fra le ombre, per scoprire la rete filigrana che unisce i rapporti umani in una vasta energia vitale, estinguendo lo sforzo inutile di qualificare una propria identità simulacra.
Ai giovani e meno giovani di oggi alla ricerca di una esperienza di caverna – quella profonda che guarisce, che apre alla conoscenza del reale, al calore dell’interrelazione umana – propongo un viaggio multimediale lungo le vie della Iniziazione moderna, passando attraverso le vostre immagini, i vostri racconti personali; una discesa agli inferi nell’inconscio collettivo per poi entrare nel mondo dei sogni. Sarete accompagnati da psicologi, musica, mito e con i mimi scoprirete come imparare il linguaggio dei simboli per comunicare con l’Invisibile.
Soprattutto affrontando i sistemi simbolici, come affermano i teorici della complessità, scopriremo insieme come «L’interdipendenza è all’origine dei nostri “condizionamenti reciproci” che caratterizzano le nostre relazioni quotidiane. Le azioni – anche quelle più piccole che spesso ci appaiono insignificanti – non
esistono di per sé ma solo in virtù delle relazioni che le generano e dell’impatto che producono nelle situazioni di vita». Queste sono le verità che amate, ci trasformano davvero e ci aiutano ad imparare a prender cura di noi stessi con gentilezza e saggezza.
Note
1 Hillman, Sogno e mondo Infero, Ediz. Comunità, Milano, 1984.